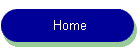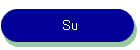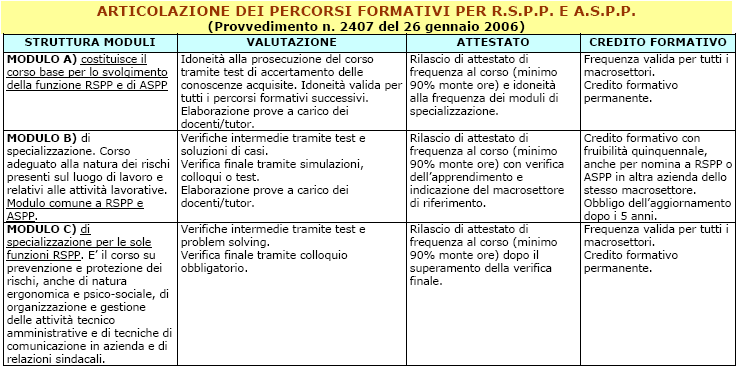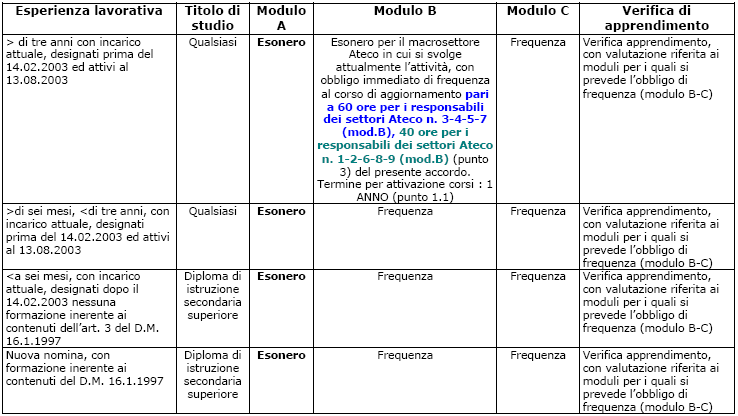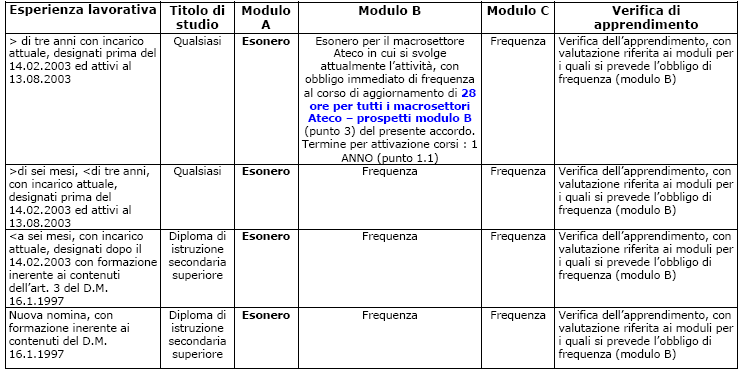|
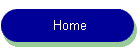
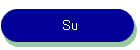
| |
-
La Certificazione dei
Sistemi di Gestione per la Sicurezza
-
La figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione
TI INTERESSA
L'APPROFONDIMENTO DI UN ARGOMENTO SPECIFICO?
RICHIEDILO A
ambrosini@stefanoambrosini.com
|
1. LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
PER LA SICUREZZA
torna all'inizio
Perché adottare un
sistema di gestione per la sicurezza? Lo scopo dell'adozione di un
sistema di gestione per la sicurezza è quello di definire, all'interno
dell'organizzazione, chiare regole e modalità per la gestione degli
aspetti di sicurezza sul lavoro in modo da garantire il rispetto di
tutte le prescrizioni normative esistenti e da ridurre, nel tempo, gli
eventi infortunistici e di malattia professionale.
In particolare, l'adozione di un Sistema di
Gestione per la Sicurezza e la sua Certificazione da parte di Organismo
esterno:
-
non è una forma di liberatoria nei
confronti delle verifiche condotte dalle Autorità Competenti;
riguarda tutti i processi, la struttura ed i siti
dell'Organizzazione interessata (catena datore di lavoro -
lavoratori);
-
richiede la preventiva analisi di tutti
i processi aziendali relativi al sito e che comunque rientrano sotto
la propria responsabilità;
-
ha come pre-requisito essenziale ed
imprescindibile il rispetto delle norme cogenti in materia di
Sicurezza e Salute sul luogo di Lavoro.
-
richiede obbligatoriamente la
documentazione della valutazione dei rischi in quanto l’eventuale
autocertificazione sostitutiva di detto documento, ancorché redatta
ai sensi della legislazione vigente, non è da ritenersi un documento
né idoneo, né sufficiente allo sviluppo delle attività di auditing
per gli scopi di certificazione.
-
richiede la predisposizione del piano
di gestione delle emergenze.
La certificazione di un Sistema di Gestione
per la Sicurezza è un atto volontario, compiuto dall'Organizzazione per
tenere sotto controllo e migliorare con continuità gli aspetti di
sicurezza sul lavoro; in pratica, con tale atto un Organismo di
Certificazione viene incaricato dall'azienda di esaminare i documenti e
di visionare le prassi operative adottate per la gestione della
sicurezza confermando, se il caso, la loro conformità alla normativa
cogente (pre-requisito) e valutandone l'efficacia in relazione alla
Politica per la Sicurezza ed ai conseguenti obiettivi e traguardi
stabiliti.
Le attività di audit condotte
dall'Organismo di certificazione, quindi:
-
prendono in considerazione tutti i
processi e tutti i turni di lavoro;
-
comportano l'esame di tutte le
procedure / prassi in uso in azienda e la valutazione di tutte le
registrazioni predisposte per fornire evidenza delle attività svolte
in ambito sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
-
prevedono la valutazione di ruoli,
responsabilità e comportamenti dei vari soggetti coinvolti (es.
responsabili attività, lavoratori, fornitori, ecc.
L’audit di un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro è
svolto in due Stages (Fasi), temporalmente separati come segue:
Stage 1: deve fornire una
visione d’insieme utile per la pianificazione della successiva attività
di auditing, permettendo la comprensione dell’architettura del Sistema
di Gestione SCR, in riferimento al contesto dei processi, dei rischi
presenti nei siti da sottoporre ad Audit e del livello di preparazione
dell’Organizzazione che ha richiesto la Certificazione, comprensivo
della consapevolezza delle risorse umane.
Stage 2: deve confermare la conformità e la coerenza
dell’Organizzazione con la propria politica per la Sicurezza, con gli
obiettivi e le procedure del sistema, assicurando che il Sistema di
Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro sia conforme con tutti i
requisiti dello standard di riferimento e che, inoltre, l’Organizzazione
si sta impegnando per il conseguimento dei propri obiettivi.
Stage 1
Questo primo livello di audit deve partire,
ma non limitarsi, dall’analisi della documentazione; la valutazione
della documentazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute
sul Lavoro viene eseguita per:
-
verificare
la sostanziale conformità della documentazione nei confronti dello
standard di riferimento.
-
valutare
la consistenza dei contenuti dell’impianto del Sistema di Gestione
rispetto al contenuto del documento di valutazione dei rischi ed a
quello per la gestione dell’emergenza.
Specificatamente, viene valutato se l’Organizzazione è pronta o meno per
l’audit Stage 2, verificando che:
-
il Sistema di Gestione SCR
comprenda un processo solido, dinamico e partecipato di
identificazione dei pericoli e valutazione dei relativi rischi;
-
siano definiti ed adeguatamente
efficaci specifici programmi e/o sistemi di manutenzione;
-
il processo di individuazione ed
analisi dei pericoli e la valutazione dei rischi sia descritto in
una specifica Procedura, che specifichi i criteri di monitoraggio
nel tempo di tali rischi e che coinvolga il personale addetto ai
diversi processi;
-
l’individuazione ed analisi dei
pericoli e la valutazione dei relativi rischi siano concretamente
l’input per il processo di miglioramento continuo;
-
esistano degli indicatori
prestazionali per la Prevenzione e Protezione, relativi ai processi
ed alle attività e che siano stabiliti adeguati obiettivi per la
Salute e Sicurezza sul Lavoro. Tali obiettivi devono essere
supportati da una programmazione e pianificazione tecnica e
finanziaria e, assieme agli indicatori, devono essere coerenti con
la valutazione dei rischi;
-
la valutazione dei rischi copra
tutti i possibili pericoli, compresi quelli derivanti dai processi
messi in essere da fornitori che operano, anche in modo sporadico,
presso il sito o quelli relativi alla presenza di visitatori;
-
i responsabili dei diversi
processi e/o attività relative alla sicurezza, previsti dalla
legislazione vigente, siano stati addestrati sui principi della
gestione e sulle tecniche per la sicurezza e che abbiano una buona
conoscenza di tali argomenti;
-
per l’esercizio dell’attività del
sito, l’Organizzazione sia in possesso di tutte le necessarie
licenze afferenti la sicurezza;
-
il livello di implementazione del
sistema suggerisca l’opportunità di procedere con l’audit in Stage
2, avendo verificato la capacità del Sistema stesso di farsi carico
e gestire le eventuali Non Conformità;
-
i risultati degli audit interni
diano evidenza della conformità ai requisiti dello standard di
riferimento;
-
sia stato programmato almeno il
primo Riesame della Direzione e che questo supervisioni
l’adeguatezza ed efficacia del Sistema di Gestione per la Sicurezza;
-
il Sistema di Gestione della
Sicurezza e Salute sul Lavoro tenga traccia e risponda alle
principali istanze delle parti interessate;
-
ad ogni lavoratore sia stato
affidato un ruolo chiaro, ben definito e noto, con la chiara
definizione delle relative responsabilità per la Sicurezza e Salute
sul Lavoro;
-
il piano di formazione ed
informazione delle risorse umane sia definito in base alla relativa
analisi delle esigenze ed attuato;
-
sia stata definita una Procedura
per l’analisi delle Non Conformità, degli incidenti , dei “near
miss” e degli infortuni, atta a determinare le cause degli stessi
eventi, al fine di predisporre, ove necessario, le opportune Azioni
Correttive.
Per eseguire le attività di Stage 1,
l’Organismo di Certificazione dovrebbe ricevere almeno le seguenti
informazioni:
-
la documentazione del Sistema di
Gestione per la Sicurezza, incluso il manuale e le procedure;
-
una descrizione
dell’Organizzazione e dei processi che si svolgono presso il sito o
quelle località coperte dallo scopo di Certificazione, come, ad
esempio, i cantieri;
-
un’indicazione dei pericoli e dei
rischi, compresa la valutazione dei rischi, che sarà impiegata anche
per la predisposizione del piano di campionamento e del relativo
piano di audit;
-
il modo attraverso il quale il
concetto di miglioramento continuo è realizzato;
-
un elenco aggiornato delle leggi
e regolamenti applicabili, incluse licenze e permessi, ed ogni altro
accordo con le Autorità Competenti;
-
i programmi ed i rapporti di
internal audit per la sicurezza;
-
l’evidenza dell’adozione, come
guida per l’implementazione e l’esercizio del sistema, dei principi
organizzativi definiti nella Linea Guida Uni INAIL, nella Linea
Guida UE ed in quella ILO;
-
la Dichiarazione del
coinvolgimento, nell’implementazione del Sistema di Gestione per la
Sicurezza, di tutti i lavoratori dipendenti dall’Organizzazione o
dai Fornitori o dai Clienti, comunque operanti presso il sito
dell’Organizzazione, ma anche dei lavoratori assimilabili ai
dipendenti, così come previsto dalle leggi in vigore;
-
una Procedura atta a consentire
un efficace flusso delle informazioni relative alla Sicurezza e
Salute sul Lavoro;
-
pratiche relative a licenze,
concessioni, autorizzazioni nulla osta o permessi;
-
registrazioni della Sicurezza
(comprese le registrazioni relative ad incidenti, violazioni
legislative o regolamentari e corrispondenza/verbali dei rapporti
con le Autorità Competenti) sulla base delle quali l’Organizzazione
ha basato le propria valutazione di conformità legislativa;
-
informazioni di dettaglio
relative ad ogni Non Conformità rilevata internamente, inclusi
almeno i mancati infortuni, così come informazioni di dettaglio
relative alle Azioni Correttive ed Azioni Preventive messe in essere
o dall’inizio dell’applicazione del Sistema di Gestione per la
Sicurezza;
-
registrazioni dei Riesami della
Direzione;
-
registrazioni relative ad ogni
eventuale comunicazione ricevuta o comunque intercorsa con le Parti
Interessate a proposito del Sistema di Gestione per la Sicurezza e
le conseguenti azioni intraprese in risposta alle stesse.
Stage 2
Tutte le eventuali Non Conformità aperte in occasione dell’Audit in
Stage 1, devono essere state chiuse e deve esserne stata verificata
l’efficacia, prima dell’inizio dell’audit in Stage 2.
Nel corso dello stage 2, i valutatori
dell'Organismo di Certificazione pongono attenzione nei seguenti aspetti
dell’Organizzazione:
-
identificazione degli aspetti
critici che possono determinare il fallimento del Sistema di
Gestione per la Sicurezza, in relazione alla situazione in essere,
quali ad esempio il clima aziendale per la Sicurezza e Salute sul
Lavoro e la valutazione della loro significatività, così come la
valutazione dei pericoli per la Salute e Sicurezza sul Lavoro e dei
relativi rischi;
-
procedure che assicurino la
conformità con gli aspetti legali, con aspetti derivanti da
regolamenti cogenti o altri documenti prescrittivi (ad esempio di
gruppo);
-
obiettivi e traguardi intermedi
derivanti dal processo di valutazione dell’implementazione del
sistema;
-
controlli operativi (intesi come
strumento organizzativo di prevenzione e guida);
-
monitoraggio delle prestazioni
del sistema, quindi misurazioni di parametri relativi alla sicurezza
per i vari processi, reporting verso la Direzione e riesami a fronte
degli obiettivi e dei traguardi intermedi;
-
efficacia del miglioramento
continuo;
-
identificazione e valutazione da
parte dell’Organizzazione delle Non Conformità ed attuazione di
Azioni Correttive e di Azioni Preventive;
-
auditing interno e Riesame della
Direzione;
-
assunzione reale di
responsabilità ed impegno da parte della Direzione;
-
collegamento logico tra le
politiche aziendali, i pericoli ed i rischi per la Salute e
Sicurezza sul Lavoro, gli obiettivi ed i traguardi intermedi, le
responsabilità, i programmi relativi agli obiettivi ed ai relativi
traguardi, le Procedure, i dati relativi alle prestazioni, audit
interni e Riesami della Direzione;
-
Il coinvolgimento di tutti i
lavoratori, sia interni all’Organizzazione, sia di quelli
appartenenti ad organizzazioni fornitrici o Clienti, in attività di
formazione e di formazione relative sia al processo dinamico di
valutazione dei rischi, sia al processo di miglioramento continuo.
torna all'inizio |
|
2. LA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
torna all'inizio
L'organizzazione del
Servizio di Prevenzione e Protezione (interno o esterno all'azienda) è
sempre obbligatoria; in particolare, è obbligatoria l'organizzazione del
servizio interno nei seguenti casi:
-
aziende industriali di cui
all'art. 1 del D.P.R. n. 175/1988 e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e
6 del decreto stesso;
-
centrali termoelettriche;
-
impianti e laboratori
nucleari;
-
aziende per la fabbricazione
e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
-
aziende industriali con
oltre 200 lavoratori dipendenti;
-
industrie estrattive con
oltre 50 lavoratori dipendenti;
-
strutture di ricovero e cura
sia pubbliche che private.
Il datore di lavoro può
autonominarsi Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e,
quindi, svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai
rischi nei seguenti casi:
-
aziende artigiane ed
industriali (eccetto quelle indicate all’art.1 del dpr 175/88) fino
a 30 addetti
-
aziende agricole e
zootecniche fino a 10 addetti
-
aziende della pesca fino a
20 addetti
-
altre aziende fino a 200
addetti
Ma quali sono i compiti del Servizio di
Prevenzione e Protezione?
Al Servizio di Prevenzione e Protezione la
81/2008 e s.m. e i. attribuisce i seguenti compiti "consulenziali" in
materia di sicurezza sul lavoro:
-
individuazione dei fattori
di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per
la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto
della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
-
elaborazione delle misure
preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;
-
elaborazione delle procedure
di sicurezza per le varie attività aziendali;
-
proposta di programmi di
informazione e formazione dei lavoratori;
-
partecipazione alle
consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di
cui all'art. 35 (riunione periodica di sicurezza per aziende con
numero di addetti superiore a 15);
-
fornitura ai lavoratori
delle informazioni di sicurezza.
Affinché il servizio di
prevenzione e protezione possa svolgere i compiti a lui affidati, il
datore deve fornirgli informazioni in merito a:
-
natura dei rischi;
-
organizzazione del lavoro,
programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;
-
descrizione degli impianti e
dei processi produttivi;
-
dati del registro degli
infortuni e delle malattie professionali;
-
prescrizioni degli organi di
vigilanza.
E quali sono le Responsabilità del Servizio di
Prevenzione e Protezione?
La ragione della
istituzione del servizio di prevenzione e protezione risiede nella
necessità, di far acquisire al datore di lavoro, obbligato ad
organizzare la sicurezza in azienda, una conoscenza globale e specifica
delle situazioni di rischio presenti nell'ambito lavorativo, valutare il
grado di intensità di esse, disponendo, possibilmente di notizie
aggiornate sulle misure più idonee a fronteggiarle.
Dal momento che tutto ciò implica il
possesso di competenze professionali e specialistiche non comuni, uno
studio accurato di realtà spesso complesse e variamente articolate e una
preparazione tecnica e giuridica che solo esperti della materia possono
vantare, è derivata pertanto la necessità che lo sforzo prevenzionale
del datore di lavoro sia affiancato ed assistito da un organismo
aziendale in grado di fornire, sia pure a livello
meramente consultivo e propositivo, quei supporti tecnici e
professionali indispensabili all'elaborazione e all'attuazione di un
efficace piano di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro inteso quale programmazione del miglioramento delle condizioni di
prevenzione e protezione.
I componenti del
servizio aziendale di prevenzione, essendo semplici ausiliari del datore
di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del
loro operato, proprio perché difettano di un effettivo potere
decisionale; in altre parole l'RSPP ha il compito di coadiuvare il
datore di lavoro nell'assolvimento dei suoi doveri, fornendogli quelle
competenze tecniche ed organizzative di cui ha bisogno, ma non ha
autonomo obbligo di effettuare controlli sulla effettiva applicazione
dei presidi antinfortunistici, in quanto privo di quella posizione di
garanzia che il legislatore ha identificato espressamente in capo al
datore di lavoro, al dirigente e al preposto, nell'ambito delle loro
rispettive attribuzioni e competenze.
Applicando le regole
generali del diritto penale ai reati contravvenzionali in materia di
sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, emerge che
si tratta di reati propri, tali da poter essere commessi solo da
soggetti che rivestano le speciali qualifiche individuate nel precetto
legislativo sanzionato, ossia il datore di lavoro o il committente nel
caso di appalto, il dirigente, il preposto, il medico competente, il
progettista, il fabbricante, il venditore, ecc., figure soggettive tra
le quali non spicca mai il responsabile o l'addetto al servizio di
prevenzione e protezione.
Se dunque vi è quasi
unanimità nella dottrina nel ritenere che l'RSPP non sia responsabile
della commissione del classico reato omissivo proprio in materia
prevenzionale vi è da segnalare, tuttavia, che qualche problema
interpretativo potrebbe insorgere con la realizzazione di un evento
lesivo di danno alla persona, ossia quando dall'omissione di una misura
di prevenzione idonea ad impedire un evento (che come si è detto sopra
di per sé non comporta responsabilità per l'RSPP) si verifichi
conseguentemente un infortunio o una malattia professionale a carico di
un lavoratore: il consulente che, agendo con imperizia, imprudenza,
negligenza o osservanza di leggi e discipline, abbia dato un
suggerimento sbagliato, oppure abbia trascurato di segnalare una
situazione di rischio, inducendo così il datore di lavoro ad omettere
l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponde assieme a
questi dell'evento di danno derivato?
Ad oggi vige il
principio in base al quale il ruolo di RSPP non comporta l'assunzione di
un obbligo di attivarsi per la prevenzione in quanto, la mera posizione
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non è da sola
sufficiente a creare una posizione di garanzia, cioè di impedimento dei
reati altrui, assimilabile a quella di un datore di lavoro, di un
dirigente o di un preposto. L'assenza di posizione di garanzia, inoltre,
esclude il reato di cooperazione colposa (Art. 113 c.p.) dell'RSPP con
il datore di lavoro, diventando questa un'ipotesi di connivenza
non punibile, applicabile quando il soggetto assiste passivamente alla
mera perpetrazione di un reato, che ha la possibilità ma non l'obbligo
di impedire.
Infine,
quali sono i requisiti necessari per il personale
del Servizio di Prevenzione e Protezione?
Il datore di lavoro che intende svolgere
direttamente i
compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve
frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro
(ad oggi ancora corso di 16 ore con i contenuti previsti dal D.M. 16 gennaio 1997,
senza necessità di aggiornamento)
e assicurarne debita comunicazione al Rappresentate dei Lavoratori per
la sicurezza.
In tutti gli altri casi, nel D. Lgs. 9
aprile 2008, n. 81, in vigore dal 15 maggio 2008, sono definiti “le
capacità ed i requisiti” minimi professionali richiesti agli addetti e
ai responsabili dei S.P.P., interni ed esterni alle aziende (art. 32). In
particolare, tale decreto definisce, quale requisito minimo per
ricoprire le funzioni di R.S.P.P. e d’A.S.P.P., il possesso di:
-
un titolo di studio non inferiore
al diploma d’istruzione secondaria superiore;
-
un attestato di frequenza, con
verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione
definiti dal Provvedimento
n. 2407 del 26/1/2006 - adeguati alla natura dei rischi sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative (art. 8-bis, comma 2).
Nella tabella sono riassunti i percorsi
formativi per RSPP e ASPP.
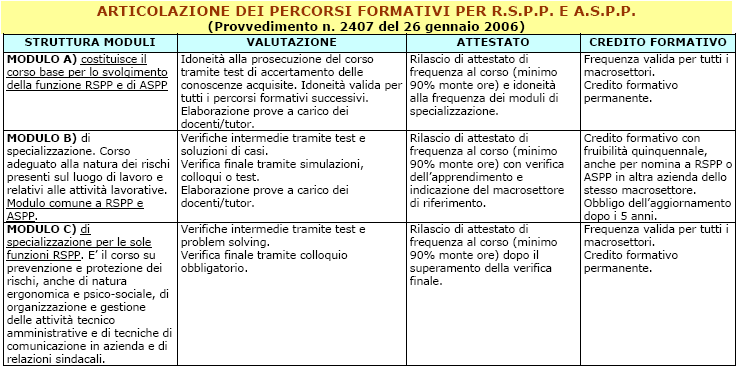
Per gli RSPP e gli ASPP "esperti", sono
riconosciuti specifici crediti formativi come da tabelle seguenti:
crediti formativi per R.S.P.P.
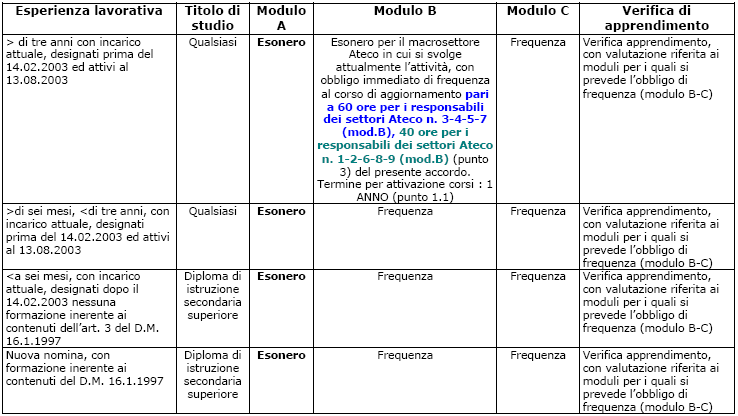
crediti formativi per R.S.P.P.
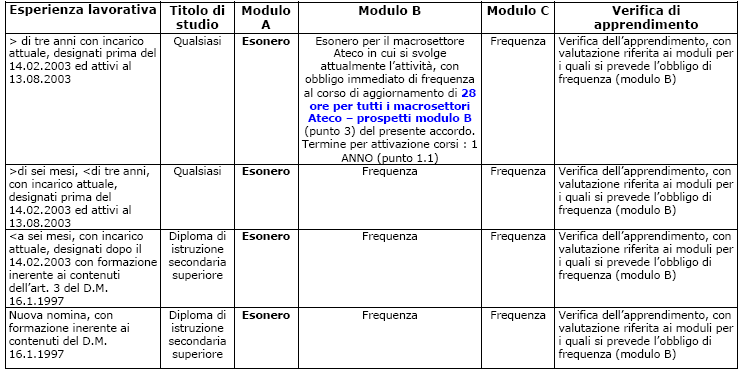
In aggiunta a quanto sopra indicato,
valgono le seguenti esclusioni: "Coloro che sono in possesso di
laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al
decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, o
nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 ovvero nella
classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, ovvero di altre lauree
riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente sono
esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione sopra indicati (ma non
dagli aggiornamenti)"
torna all'inizio |
|